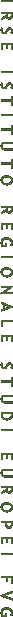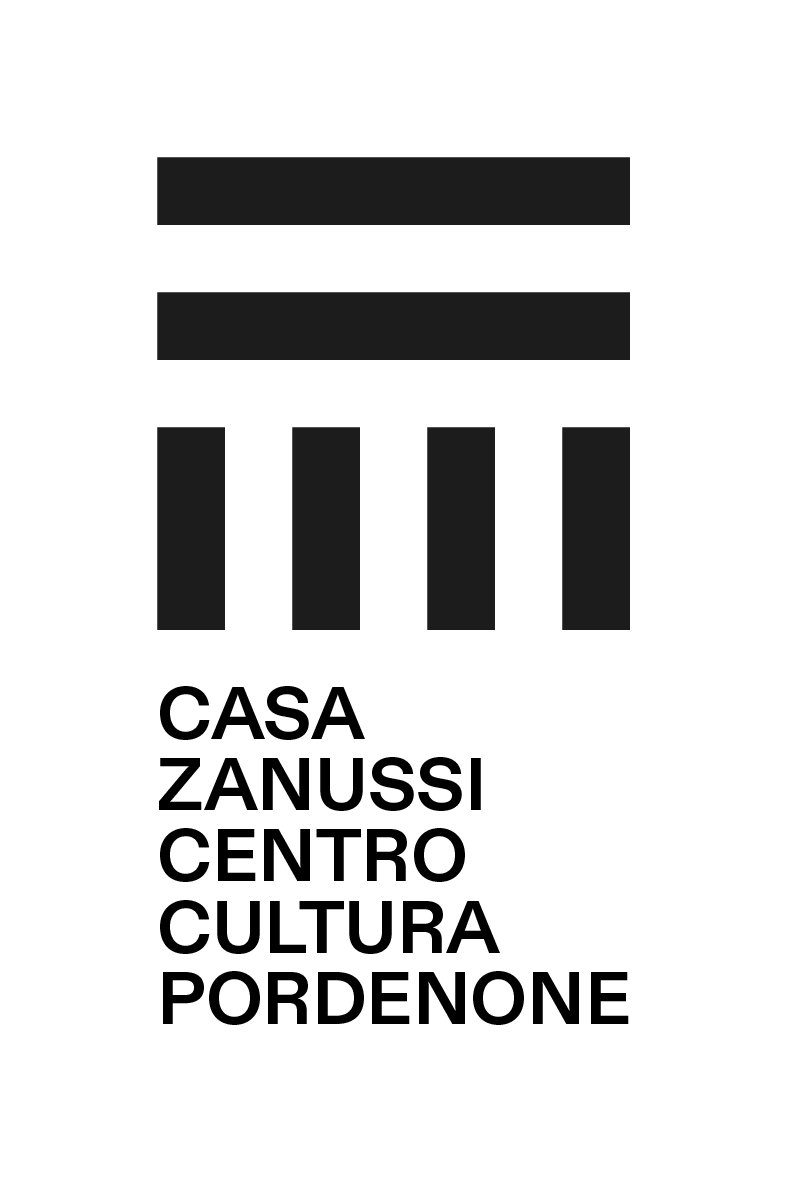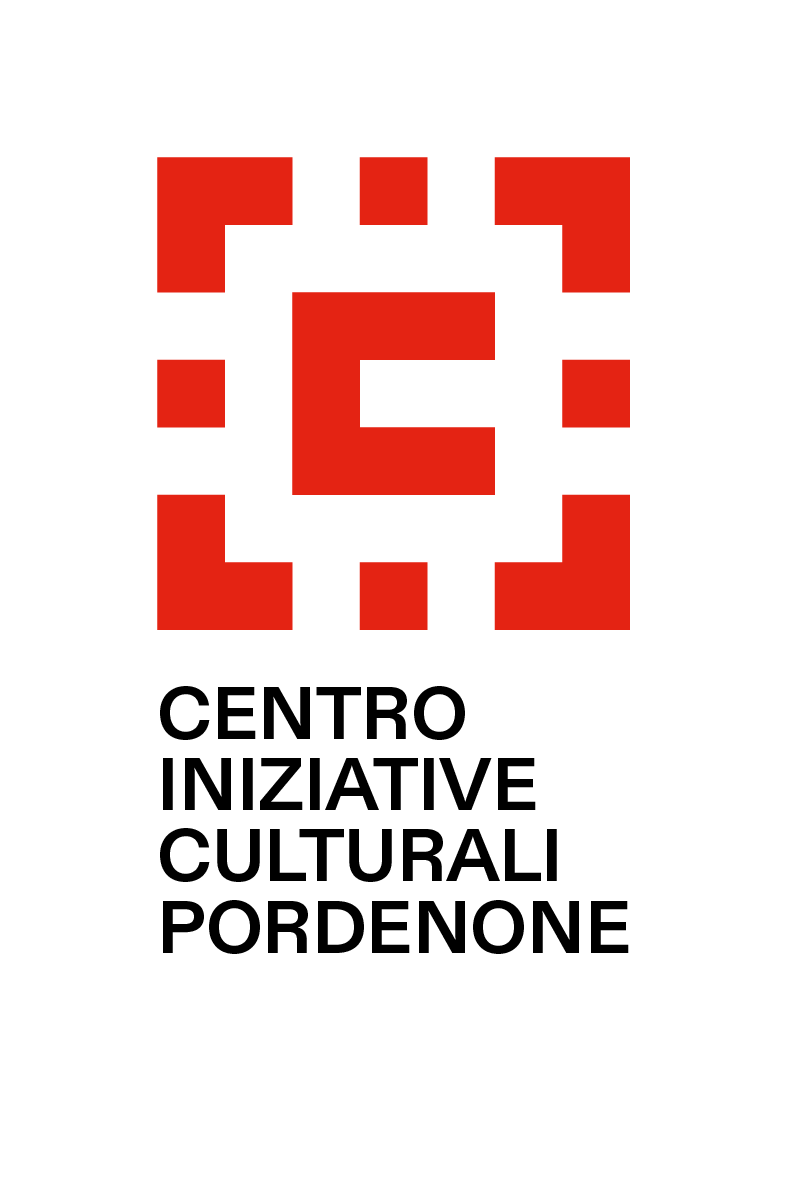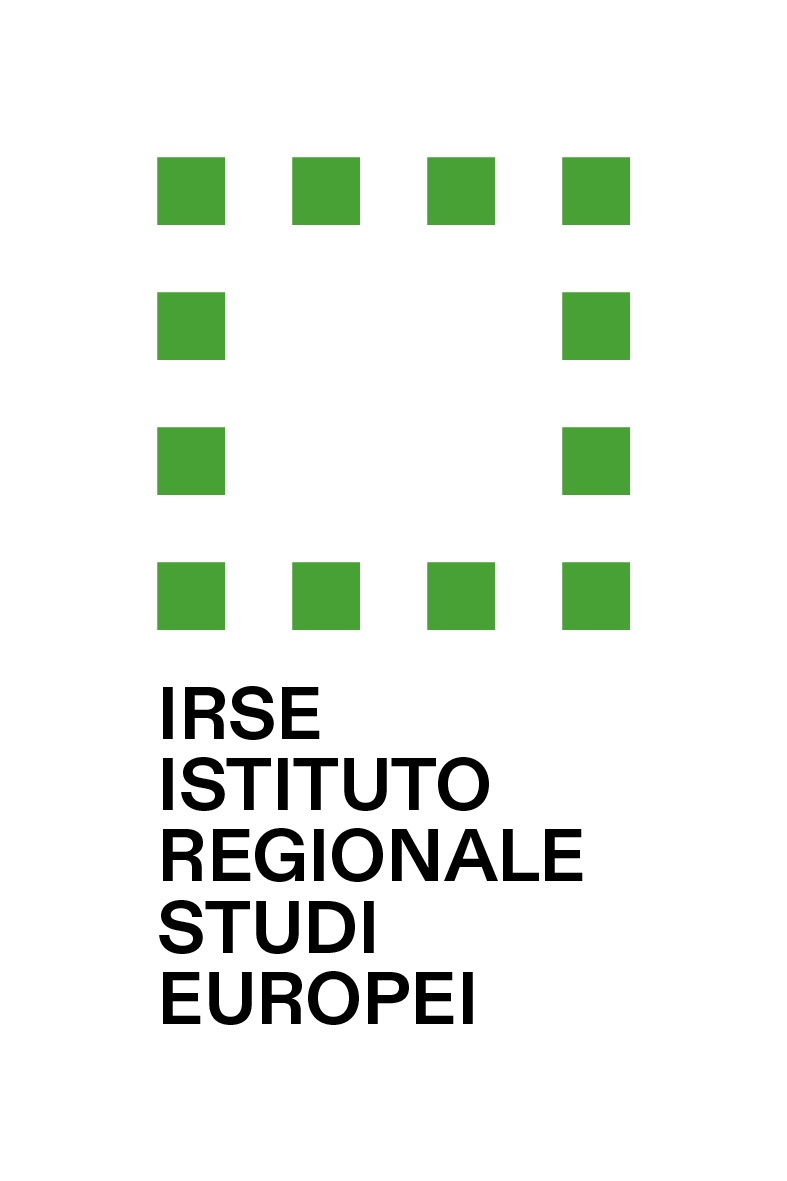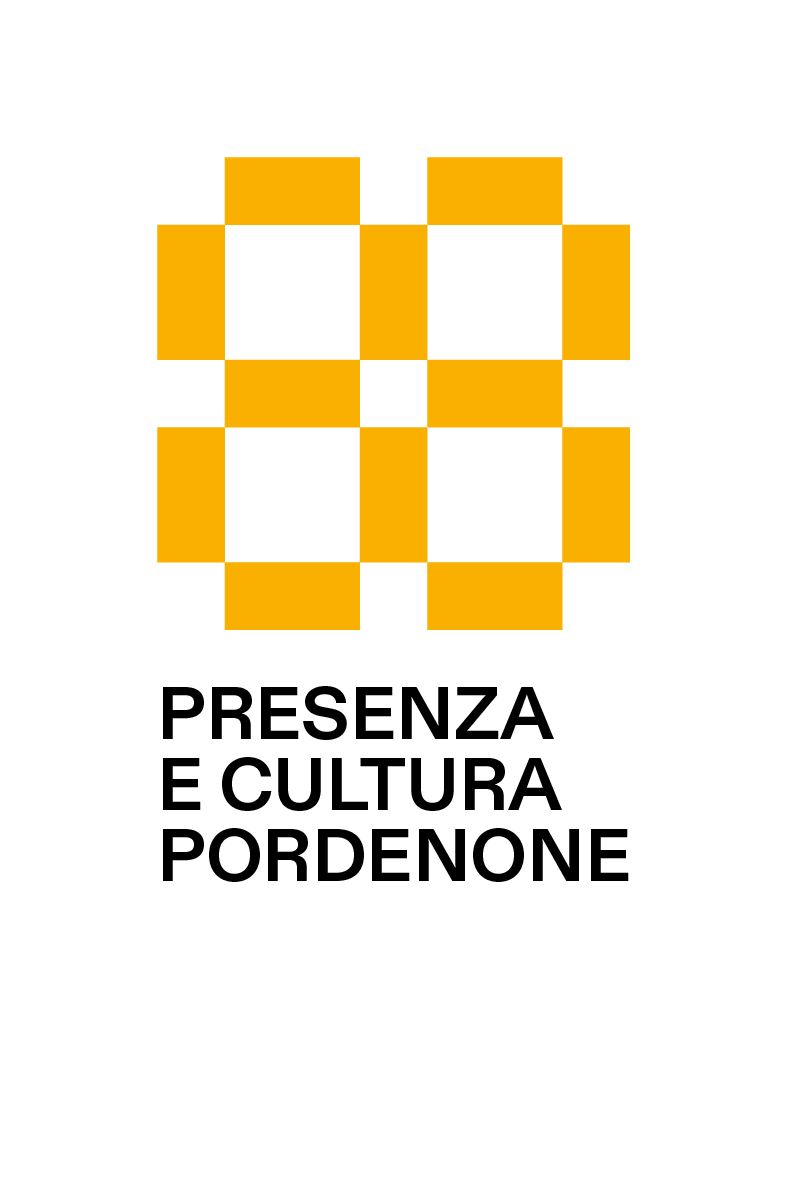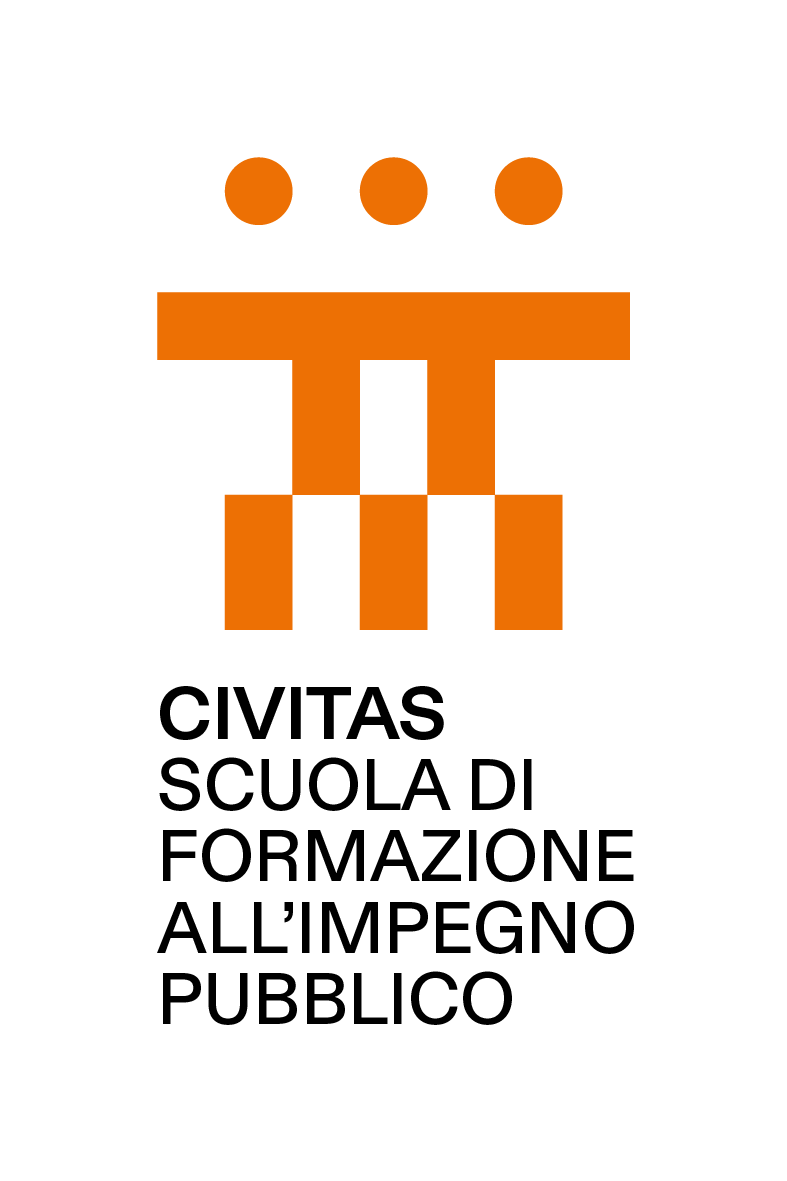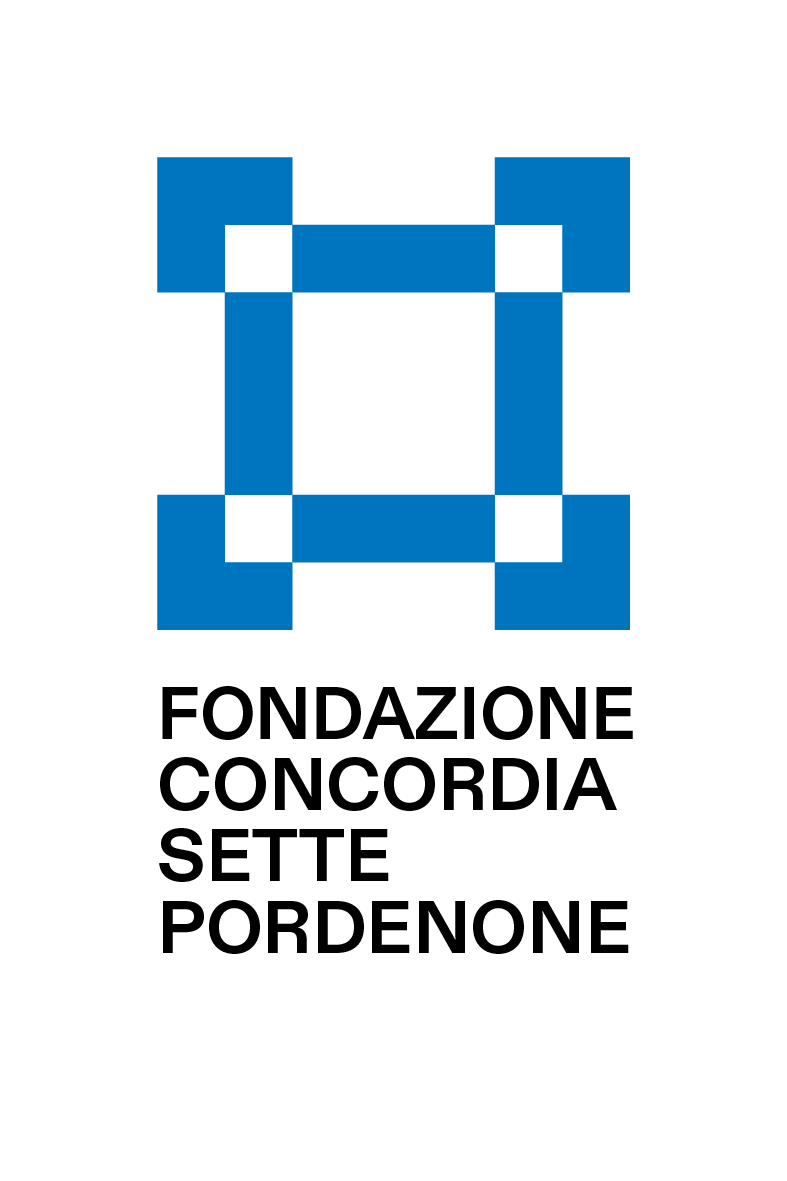Elisa Cozzarini
Terzo classificato - Sezione Senior
La sera i black out sono frequenti ad Oussouye e tutto sprofonda nel buio, anche per diverse ore. Rimangono solo la luce della luna e migliaia di stelle, che filtrano tra le foglie di alberi giganti di mango. Cammino tenendo stretta la mano di Kadja, perché sono totalmente disorientata nell’oscurità della notte, tra denti bianchi e occhi fluorescenti attaccati al volto di persone che non potrei mai riconoscere.
Kadja invece si ferma e scambia quattro chiacchiere con tutti, presentandomi come l’ospite tubab (cioè bianca). Nessuno in Africa ha tanta fretta da non avere il tempo per parlare con chiunque incontra per strada. È un altro mondo: appena arrivata a Dakar, con il mio passo da friulana che scala i monti, non ancora adattata ai ritmi africani, un signore mi ha fatto notare che non stavo gareggiando in Formula Uno.
Ora sono ospite della famiglia Mballo ad Oussouye, la regione più a sud del Senegal, ribelle e dalla storia tormentata. Ma io mi fido ciecamente perché quaggiù non sono arrivata a caso: mi ha mandato un amico immigrato in Italia. Secondo me questo è il modo migliore per viaggiare sicuri e passare una parentesi della vita immersa dentro una cultura e un paese diverso.
Ho una stanza tutta per me, che è come una casetta, in cemento, affacciata sul cortile interno di casa Mballo. Lo spazio in comune è separato dall’esterno con un cancello in lamiera abbastanza alto da nascondere cosa succede all’interno, ma sempre aperto. Nel cortile si mangia, si beve il tè, si chiacchiera, ci si incontra, si vive.
Il bagno è dall’altro lato rispetto alla mia camera e ciò significa che tutti sanno quando vado a farmi la doccia o altro, un po’ come in campeggio. Scopro che la privacy è decisamente limitata, nelle famiglie allargate senegalesi. Solo quando vado a dormire sono davvero sola, perché se appena mi metto fuori a leggere o scrivere, c’è sempre qualche fratello, cugino, zio, nipote che si preoccupa per me e mi offre il delizioso caffè tuba, che profuma di spezie.
Kadja mi sta portando a casa della prima moglie di suo marito. Lei è la seconda, ma io tutte queste cose le intuisco man mano che procediamo. Fa caldo e sono tutti all’aperto, circa dieci persone tra uomini e donne, mentre i bambini sono già a letto, sfiniti da una giornata di giochi all’aperto. Il marito di Kadja, un uomo magro altissimo e sorridente, prepara il tè della teranga, cioè del benvenuto.
Una signora molto grassa, distesa a terra su una stuoia, alza la testa e la appoggia lentamente su una mano: tutto questo sforzo per chiedermi se la riconosco. Kadja mi suggerisce che l’ho incontrata la mattina al mercato, è la venditrice di frutta e verdura. «Mi porti in Italia con te?», chiede la donna ridendo. Tutti ripetono la stessa domanda, come un mantra, perché non c’è un africano che non sogni l’Europa, anche se c’è la crisi e gli emigrati raccontano che la vita qui non è facile. «Inshallah, se Dio vuole», rispondo con un sorriso, respirando l’aria fresca che muove le foglie di mango.